Lo stress lavoro-correlato e il burnout rappresentano oggi alcune delle sfide più complesse nel mondo del lavoro.
Sono fenomeni che vanno oltre il disagio individuale, influenzando profondamente la produttività aziendale, la sostenibilità economica e, più in generale, il benessere della società.
Lo stress lavoro-correlato è una risposta fisica ed emotiva che si manifesta quando le richieste lavorative eccedono le capacità e le risorse del lavoratore per gestirle.
Non si tratta di una condizione passeggera, ma di un fenomeno che può cronicizzarsi e compromettere salute e produttività.
Le cause principali includono un sovraccarico lavorativo (carichi di lavoro eccessivi, scadenze serrate, eccessiva responsabilità), ruoli ambigui o conflittuali (mancanza di chiarezza sulle mansioni o aspettative contrastanti), mancanza di controllo (scarsa autonomia decisionale, senso di impotenza nel proprio ruolo) e carenza di supporto (relazioni difficili con colleghi e superiori o mancanza di riconoscimento).
Il burnout, strettamente legato allo stress, è stato formalmente riconosciuto dall’OMS come un fenomeno occupazionale e si manifesta con esaurimento emotivo (sensazione di svuotamento, mancanza di energia e difficoltà a recuperare), cinismo o distacco (percezione negativa delle mansioni e ridotto coinvolgimento emotivo) e ridotta efficacia personale (senso di incompetenza e mancanza di risultati, spesso accompagnato da un’autocritica intensa).
I settori sanitario, tecnologico ed educativo sono tra i più colpiti dallo stress lavoro-correlato e dal burnout a causa delle specifiche caratteristiche e pressioni di ciascun ambito.
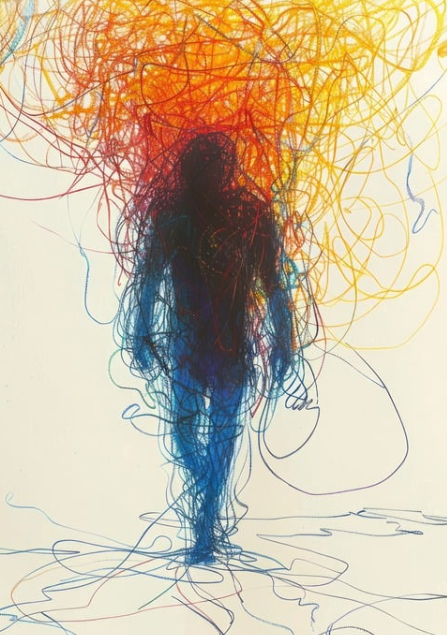
In Europa, il 44% dei lavoratori dichiara di sentirsi frequentemente stressato, con un aumento significativo attribuito alla pandemia di COVID-19, che ha aggravato problematiche già presenti. Si stima che la perdita economica globale legata ai disturbi mentali sul lavoro superi i 1.000 miliardi di dollari all’anno, includendo assenze per malattia, ridotta produttività e turnover del personale. I numeri allarmanti non catturano, però, appieno il costo umano: le giornate perse, i rapporti deteriorati, il potenziale personale sprecato.
Negli Stati Uniti, il 76% dei lavoratori ha vissuto almeno una volta un episodio di burnout mentre in Asia il termine karoshi evidenzia il fenomeno della “morte da superlavoro” per evidenziare le lunghe ore di produzione a cui sono sottoposti i lavoratori.
In Italia, secondo dati Inail, nel primo trimestre 2023, le denunce per malattie professionali, legate alla salute e al benessere psicologico, sono aumentate del 17,9%.
Affrontare questi problemi richiede la capacità di riconoscerli. I segnali non sono sempre evidenti e spesso vengono ignorati o minimizzati sia dai lavoratori che dai datori di lavoro. La paura di ripercussioni sulla propria carriera spinge molti ad esitare di chiedere supporto (circa il 50% dei lavoratori europei).
Ci sono, però, esempi virtuosi che dimostrano che un approccio diverso è possibile. Nei Paesi scandinavi, politiche di work-life balance e una maggiore flessibilità lavorativa hanno contribuito a ridurre significativamente lo stress lavoro-correlato e il burnout.
Alcuni programmi includono consulenze psicologiche gratuite, formazione per i manager sulla gestione dello stress e orari di lavoro più flessibili. In Germania, per esempio, diverse imprese hanno introdotto controlli regolari sulla salute mentale dei dipendenti, offrendo strumenti concreti per affrontare situazioni di disagio, in Giappone la Microsoft ha sperimentato la settimana lavorativa di 4 giorni, registrando un aumento del 40% della produttività e una riduzione dello stress tra i dipendenti.
Parallelamente, la legislazione europea ha iniziato a muoversi in questa direzione con il quadro strategico 2021-2027 per la sicurezza e salute sul lavoro, che invita le aziende a integrare misure preventive contro i rischi psicosociali.
La Giornata Mondiale della Salute Mentale, con il focus sulla salute mentale nei luoghi di lavoro, ha messo in evidenza come solo un approccio collaborativo tra governi, aziende, organizzazioni sindacali e lavoratori possa portare a un vero cambiamento.
In Italia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha stanziato fondi per migliorare l’accesso ai servizi di supporto psicologico, ma è necessario un impegno più ampio per affrontare le disuguaglianze che persistono in molti settori.
Investire nella salute mentale non è solo una responsabilità sociale.
Il lavoro, nella società moderna, è molto più che una fonte di reddito: è una dimensione identitaria. Le aspettative sociali di produttività, efficienza e successo personale hanno progressivamente amplificato il peso psicologico che si associa alle attività lavorative. L’intensificazione del lavoro, fenomeno osservato in diversi settori, si manifesta attraverso richieste crescenti, ritmi frenetici e una maggiore difficoltà a separare vita professionale e personale. In questo contesto non solo si alimenta lo stress cronico, ma anche una percezione diffusa di alienazione, in cui il lavoratore si sente come un ingranaggio sostituibile all’interno di un sistema economico orientato principalmente ai risultati.
La sociologia del lavoro evidenzia che categorie vulnerabili, come le donne, i giovani precari e i lavoratori in settori poco regolamentati, sono maggiormente esposte ai rischi psicosociali. La disparità di genere, ad esempio, si manifesta non solo nei salari, ma anche nella distribuzione del carico emotivo e organizzativo legato al lavoro.
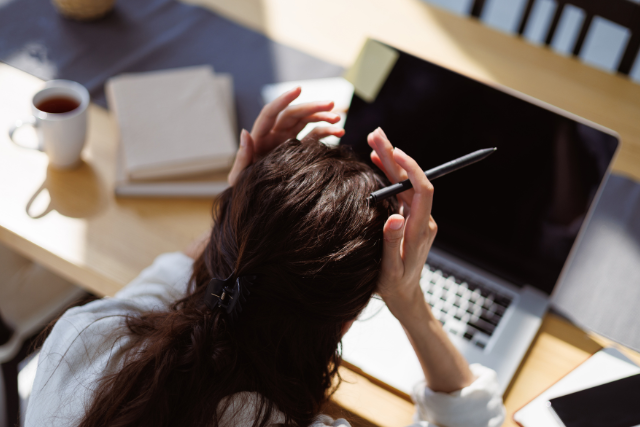
Il burnout stesso, oltre a essere un fenomeno individuale, riflette il fallimento di un sistema che non valorizza adeguatamente le risorse umane. Come descritto da Herbert Marcuse nella sua analisi critica del capitalismo avanzato, il lavoro diventa spesso un meccanismo di controllo sociale, dove il tempo e l’energia delle persone sono completamente assorbiti da obiettivi che raramente coincidono con i loro interessi o valori personali. Il distacco tra lavoratore e finalità del proprio lavoro è alla base di molti fenomeni di disagio psicologico.
La Giornata Mondiale della Salute Mentale 2024 invita a riflettere su queste dinamiche strutturali. Non si tratta solo di promuovere strategie individuali per la gestione dello stress, ma di ripensare il lavoro come spazio di partecipazione, autonomia e realizzazione personale.
La gestione dello stress lavoro-correlato e il burnout richiede un cambio di paradigma, dove il benessere delle persone sia posto al centro delle politiche organizzative e delle pratiche quotidiane. La salute mentale non è un beneficio accessorio, ma un diritto fondamentale e una condizione essenziale per una società giusta e produttiva.


